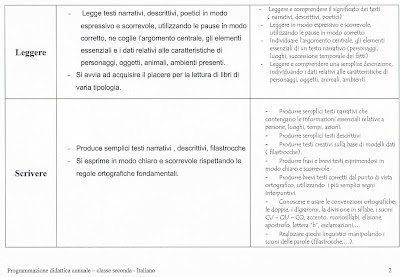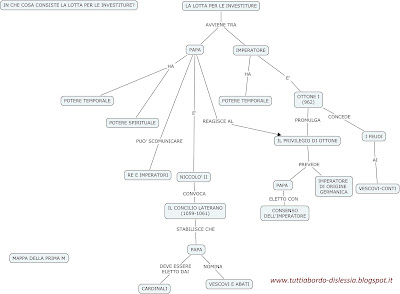Questo è un post eccezionale, in quanto è storico: mai è stato pubblicato un intero libro in un post Facebook. Lo pubblica l’Italia, nella persona di me stesso. Il libro in questione si intitola “Discorso fatto agli uomini dalla specie impermanente dei cammelli polari” e fu pubblicato nel 2010 da :duepunti edizioni di Palermo. Si tratta di una sorta di operetta morale, i cui protagonisti sono strani animali pensanti e parlanti, ovvero cammelli candidi che risiedono al Polo. Oggi questo testo torna disponibile, il che significa che nessun editore lo stamperà, perché nel corso di cinque anni si è trasformata radicalmente la scena culturale, cosicché a pochi interessa di un testo e ad ancora meno di un nome, in questo caso il mio. Tuttavia ad alcune persone potrebbe incuriosire. Per questo lo metto a disposizione qui e anche fuori dal social network. Ecco dunque un intero libro in un post.
Giuseppe Genna
DISCORSO FATTO AGLI UOMINI DALLA SPECIE IMPERMANENTE DEI CAMMELLI POLARI
“Provatevi a respirare artificialmente, e a fare pensatamente qualcuno di quei moltissimi atti che si fanno per natura; non potrete, se non a grande stento e men bene. Così la tropp’arte nuoce a noi: e quello che Omero diceva ottimamente per natura, noi pensatamente e con infinito artifizio non possiamo dirlo se non mediocremente, e in modo che lo stento più o meno quasi sempre si scopra”.
Giacomo Leopardi, Zibaldone di pensieri, 1.8
Amiche e amici,
viaggiatori scriteriati e visionari non ebbero il coraggio, prima che cessasse il flusso ematico circolatorio nei loro involucri corporei in pieno gelo, di testimoniare su carta, con inchiostro anche delebile (purché la cosa fosse scritta!), l’esistenza di fenomeni anomali nelle vaste rade ghiacee intorno al punto in cui l’asse magnetico fora la terra, e ne fuoriesce in pieno Antartide: il Polo.
Il cuore puntiforme, dissoluto e basculare del pianeta.
Tali viaggiatori, Caboto delle cime di Ongal e della barriera di Ross, calpestatori di diomedee impallidite e ossidate sotto lo strato di cristalli gelidi, calzando quelle pedule ramponate con le stringhe di cuoio a più giri e i nodi gonfi di acqua, indossando occhiali a lenti imbrunite con fiamme fragili, disperando dei soccorsi che in situazioni estreme essi sapevano non li avrebbero mai raggiunti, slacciati gli arti in tende sferzate dai venti catabatici che corrono a trecento chilometri orari, dispersi quei corpi poco prima di esalare l’alito vitale lontani dalla temibile foca leopardo (che è tale perché carnivora), hanno osservato distanti, eppure nitidamente, le sagome in fila lineare ordinata dei Cammelli Polari e non ne hanno rilasciato testimonianza alcuna. Al punto che neanche si è sviluppata, intorno a tali curiosi o inquietanti esseri (come tutto, a questo mondo, il giudizio dipende dalla prospettiva), una leggenda, una diceria colma di fantasticherie, la malizia di sfogo del fenomeno umano, giunto a tali proibitive longitudinalità.
I Cammelli Polari, che qualcuno senza dirlo ha visto e conosce e riesce a distinguire perfino non in regioni ardue qual è la Landa di Marie Byrd – codesti Animali non risultano essere idee sulla cosa, e neanche la cosa stessa.
A volte, per distrazione nel presonno, è stato possibile a qualunque giovane intercettarli con la vista annebbiata, ma l’indolenza e il gusto sommariamente buono della stanchezza (questo zucchero corporeo!) lo hanno impedito. All’inizio della fine dell’inverno, poniamo in marzo, si avverte come un suono nella mente. Sarebbe uscito all’aperto chi allora avesse veduto, incolonnati, serafici, che masticavano non si conosce quale fibra, i bianchissimi Cammelli Polari incedere a loro modo virtuosi, maestosamente in quanto evidentemente indifferenti a tutto, a qualunque sorte, quasi non vedessero altro che il proprio movimento di avanzare, sparutamente ma non per questo in debole maniera, in questo mondo che non è loro proprio. Non dal vasto ventriloquio di cartapesta sbiadita del sonno il sole sarebbe venuto all’aperto: ma soltanto la vista che avesse còlto quel lieve ondeggiare delle chine, quelle gobbe lanute e candide, quegli occhi tutti pupilla che fissavano avanti a sé, in una forma di meditazione animale o, se si vuole, di saggezza non umana, che anche i gaviali del Gange sanno imprimere all’aria, medium instabile attraverso cui si realizza il precarissimo fenomeno della visione.
Osservare in fila, quasi buddici, i Cammelli Polari sembrerebbe significare all’incirca o a pena che senza fatica viene raggiunta una nuova conoscenza del reale.
Del resto essi stessi sono distanti dalla fatica quanto un universo dall’altro. Paiono pattinare, pure ondeggiando con ritmica sollecitudine, sul suolo terreno, non accorgendosi di ciò che spezza il silenzio per chi è sottomesso al giogo dell’udito. Non hanno in odio la percezione, ma ne sembrano immuni, eppure sono capaci di grandi racconti: storie, saghe, aneddoti. Essi infatti sanno parlare.
Discreti e sussurranti, appaiono per un attimo e subito sono scomparsi.
Non assomiglia, il contegno loro, a quello del più volgare, in quanto che carnalissimo, cammello battriano che siamo soliti osservare tra le steppe anatoliche, con quella pesante gobba da mezzo quintale a dondolare disarmonicamente, i membri artiodattilici quasi quasi usciti dal fango della creazione sempre or ora, un attimo addietro. E nemmeno a quello del pur apparentemente ineffabile dromedario, che non è tale in realtà, poiché veracemente menefreghista.
I Cammelli Polari si direbbero angeli, se lo fossero.
Nelle zone più interne dell’Antartide, oltre il Monte Erebo, li si vede comparire (incerte sagome allineate, ruminanti) e subito sparire nei vortici dei blizzard più confusi, per riapparire poi come se i vortici aerei non li sfiorassero.
Pare che non vivano eventi da narrare, invece essi asseriscono, quando sussurrano le loro spontanee verità, di avere testimoniato tutto, dagli esordi.
Amano i venti antartici, i Cammelli Polari. L’origine dei venti in Antartide è determinata decisamente dalle masse fredde di ghiaccio alle alte quote. La perdita di calore per irraggiamento produce uno strato superficiale di aria assai gelata, che corre secondo precisi condizionamenti imposti dalla superficie topografica del ghiaccio. Questi venti di caduta, o catabatici, sono generalmente i più caratteristici dell’Antartide e i Cammelli Polari li prediligono quale veicolo: è in essi che quasi sembrano incarnarsi, se la loro fosse carne e non la è. I venti di discesa acquistano in potenza lungo il pendio ed ai piedi del pendio che dal plateau centrale antartico porta alle zone costiere: ed eccoli slittare, i Cammelli Polari, senza che il loro corpo apparentemente svolga alcun lavoro, se non quell’ondeggiare che inganna lo sguardo di chi sa coglierne l’andatura. Non va dimenticato che i venti discendenti sono la causa primaria delle condizioni quasi costanti delle tormente di neve, ovverosia i suddetti blizzard, vortici in cui i Cammelli Polari sembra amino inserirsi, affinché la loro pallida manifestazione appaia ulteriormente precaria.
Nelle regioni più interne del continente antartico i venti di discesa, a cui sembra tanto legata la vita dei Cammelli Polari (se vita è, anche sotto il risguardo fisiologico), tali venti spesso si dispongono dalla stessa direzione, con il risultato di dare origine alle caratteristiche configurazioni a duna della superficie nevosa, che si dice sastrugi. È su questo tappeto a dune che, a volte sulla linea costiera superiore e a volte invece inabissandosi per poi fuggevolmente riapparire risalendo le chine, i Cammelli Polari sono visibili a coloro che purtroppo, fino a questo momento, non sono stati in grado o addirittura non hanno voluto scriverne, eludendo questo nostro mondo l’esistenza di tale indeterminata specie.
I Cammelli Polari potrebbero essere fatti di luce oppure di forza vitale, anche in privazione di un organo cardiaco. L’universo infatti è in grado di vivere pur non disponendo di un organismo.
I Cammelli Polari sanno, si diceva, parlare.
Essi raccontano instancabilmente, a saperli ascoltare, nella loro lingua digitale, nivea, ulcerata dalla luce.
A volte svoltano e puntano diritto alla vista interiore, si avvicinano, perfino minacciosamente, sono pronti a estinguere te.
Li si può osservare di profilo, un Cammello Polare dietro l’altro, non che quello in apertura di colonna rivesta ruolo alcuno gerarchico, essi sono spontanei e dispongono di loro piste da battere, vie dei canti che le loro antenne sciamaniche, evidentemente tutte interiori, conoscono da generazioni per misterica trasmissione.
Così li osserveranno le lettrici e i lettori amiche e amici. Dietro la colonna ordinata dei Cammelli Polari, che si muovono all’unisono, pare, seppure non si comprenda a quale suono rispondenti, la zampa anteriore destra in avanguardia, seguita dall’incrociata posteriore, e poi via dalle altre, con i medesimi ritmi, le medesime ondulazioni verticali, dirittissima e per nulla preoccupata l’andatura, quasi che si trattasse di ombre cinesi di colpo manifeste in luce propria o di sagome cartonate di un gioco meccanico come appaiono certe wunderkammer. E dietro di loro, mai ferme e circolari, ruotano, come in un diorama, le scene più significative, e le meno, della intera storia umana: illuminate da una fonte di luce che sta dietro, alla pari proprio di una lanterna magica. Sono quadri staccati di vita di comune persiana medioevale, di corte pontificia in epoca barocca, di fumarole in pieno sviluppo neanderthaliano, di boschi inabitati dagli sami lapponi, di cinesi Han che omaggiano il mandarinato appena elevatosi, di esplorazioni subsahariane condotte da avventurieri italiani, di discussioni marmoree in una piazza lercia greca ben prima dell’arrivo del santo Paolo, di attentati accanto a prati fosforescenti in città di bianchi cementi nella seconda metà del Novecento Usa, di monasteri rinascimentali in cui copisti abiurano alla vista incantandosi fuori della finestra, in brefotrofi nordeuropei dove bambini solitari e impacciati per deformazioni fisiche emettono stridii, nelle terre rosse battute dai piedi nudi di aborigeni australiani – ovunque. Sempre, in qualunque istante, presenti o meno umani ma più spesso presenti, in queste scene istoriate sulla latta piattissima, laccate, minuziosamente rifinite, dove si osservano pettirossi indicati da un bambino e una bimba egualmente paffuti, produttori di zuccheri colorati nel secolo industriale americano, carpentieri che non si comprende da subito essere intenti a erigere il Taj Mahal, banchettatori siamesi prima della nascita dei molteplici Buddha, seguaci di Simón Bolívar feriti a morte e dissanguatisi, la soffitta austriaca della casa borghese con i balocchi che inquietano nella polvere – scene e scene e scene dal diorama della Storia Umana, tutte, tutti i momenti ovunque vissuti, stati, anche i non certificati esserci stati ma che ci furono sebbene nessuno fosse lì a testimoniarli con la sua colla percettiva, in ogni continente e prima addirittura della deriva degli stessi, in qualunque ambiente e in ogni tempo, ogni momento una scena, ogni scena un quadretto che lentamente, a sbalzi girevoli da gioco artigianale, in tale finzione passano dietro la marcia orizzontale e indifferente dei Cammelli Polari.
È con un’unica voce interiore, questa pacata telepatia sonora, che essi stessi pronunciano quanto hanno da dire a tutti, al fenomeno rude umano che ritiene di disporre di questa sfera terracquea in disperata rincorsa della fine del proprio sole. Essi ci dicono così, ci forniscono la seguente comunicazione, la medesima che hanno sussurrato negli orecchi di imperatrici e papi, dignitari e presidenti, monarchi e negus, sovrani ed emiri, raja e sultani, kaiser e nizam, principi e khan, scià e cardinali, califfi e valvassini, nababbi e malik, grandezze e burgravi, siniscalchi e zar, langgravi e delfini, duchi pari ed esquire, effendi e arcivescovi, patrizi e infanti, hidalgo e vicerè, coppieri e lugal. A tutti così è stato riferito, il messaggio dei Cammelli Polari, dai medesimi*:
DISCORSO TENUTO AGLI UOMINI PRIVI DI POTERE OVVERO NO DA PARTE DELLA SPECIE IMPERMANENTE DI NOI CAMMELLI POLARI
«Amiche e amici,
molti misteri hanno visitato, visti di scorcio, oppure anche frontalmente e non compresi, proprio come questa falsa forma di esprimersi, l’impermanente specie degli uomini. Nella nazione messicana, non più tardi di qualche anno addietro (sia pure accada che divenga difficile localizzare l’avverbio di luogo diventato di tempo: questo mistero linguistico tramuta lo spazio in cronologia), ci si incuriosì per via delle fotografie scattate che furono a quello che i media locali immantinente etichettarono “bambino extraterrestre”. La sua cattura e successiva uccisione risale al 2007 dopo la nascita di quel magistrale figlio dell’uomo Cristo, ma i media ne hanno parlato soltanto di recente: e ciò significa, a un anno dai fatti. Così petroso è il rovinare del tempo. Tutto cominciò quando un gruppo di contadini messicani ritrovò in una fattoria il piccolo essere: deforme, gelatinoso quasi, la epidermide liquefacentesi e grigiastra, la testa notevole. Spaventati e increduli tentarono di soffocarlo per ben tre volte, riuscendovi soltanto dopo che lo ebbero tenuto, e per molte ore, sottacqua.
Per gli esperti della università locale, il corpo non appartiene a una specie terrestre. Il corpo medesimo venne subito condotto, piccino e attorniato di interroganti, alla università locale e i risultati delle analisi destarono fino da subito grande sorpresa: il piccolo corpo non apparterrebbe infatti a nessuna specie vivente conosciuta. Presenta sì alcune caratteristiche morfologiche umane e però anche di rettile, come – ed è soltanto un esempio – la dentatura senza radici, oltre ad un certo grado di sviluppo cerebrale. Gli studî della università assicurano non trattarsi di un falso né di una montatura, ma di un fatto che, almeno fino al momento in cui questo discorso cade pronunciato, ebbene, risulta inesplicabile.
I ricercatori fecero un gran numero di fotografie al corpo piccino e le immagini di quello insolito essere stanno ora facendo il giro del mondo. “Sono certo siano autentiche”, giura tale Jaime Maussan, un messicano ufologo.
Intanto il mistero sul “bambino alieno” si infittisce ulteriormente – come, del resto (è cosa bennota), qualunque mistero: è tutto infittimento. Infatti, nel frattempo, Marao Lopez, uno dei contadini che individuò e uccise per annegamento lo strano essere, è morto. Il suo corpo, completamente carbonizzato, è stato ritrovato all’interno della propria auto al bordo di una strada. Il suo veicolo, stando a quanto appurato dagli esperti, non sarebbe rimasto coinvolto in un incidente ma avrebbe preso fuoco per cause ignote, raggiungendo temperature definite “anomale” e la portiera era chiusa dall’interno. Questi particolari hanno condotto alcuni messicani a ritenere che nel grave fatto consista la vendetta dei genitori del piccolo alieno ucciso per annegamento dai contadini messicani. “Il dolore provato dai familiari dell’alieno – ha commentato la vedova di Marao Lopez il contadino – deve esser stato talmente acuto, talmente inarginabile, da permettere che covasse in loro il desiderio di vendetta, in ispregio a qualunque precetto di pietà cristiana per il nostro legittimo ribbrezzo a fronte di quell’essere inquietante e mostruoso. Reagiscono alla medesima maniera gli animali: pertanto non è difficile immaginare possano farlo esseri intelligenti e tecnologicamente evoluti”.
Noi Cammelli Polari non reagiamo affatto a questa maniera.
Noi incediamo né sicuri né insicuri, al di là – vorremmo dire – di ogni plausibile idea di sicurezza dell’incedere, il nostro passo calca polveri sottili e spesse, siamo indifferenti al tempo che passa, il quale in realtà sotto la nostra prospettiva non passa al modo medesimo in cui non passiamo noi. Ciò non significa che siamo eterni, poiché qualche inizio dovremo pure averlo avuto, e quindi anche una fine secondo la legge universale avremo, però ce lo siamo scordato, l’inizio, e alla fine non pensiamo mai. Noi non pensiamo.
Pensiamo soltanto qualora desideriamo formulare discorsi, però è necessario che l’udito sia sottile moltissimo, per percepire il nostro sussurro e qualche insegnamento o utilità, bene o male, trarne.
Non siamo inclini a parlare di noi stessi, però bisognerà per intenderci che lo si faccia, altrimenti chissà cosa diviene possibile immaginare, e non solamente nel Messico tra i contadini.
Noi siamo i Cammelli Polari in quanto cammelli e in quanto solitamente risediamo al Polo. In quanto cammelli, evitiamo di bere spesso, per necessità naturali. Sebbene il Polo infatti sia composto in gran parte d’acqua, come è noto essa si trova in uno stato ghiacciato, e quindi risulta imbevibile. Che si sia nel deserto, laddove non v’è traccia alcuna del prezioso liquido, oppure al Polo, la situazione è la medesima ed è cosa imprescindibile fare tesoro in una specifica tasca o gobba o ansa, di cui la natura eventualmente abbia dotato, dell’acqua, elemento basilare al mantenimento della vita in questo mondo.
Il nostro manto è candido, sia pure detto albino.
I nostri grandi occhi neri lievemente inclinati a mandorla fissano sempre avanti a sé il nulla, quasi incantati, a volte all’improvviso uscendo da un tale stato per fissare intensamente (quasi mirandolo) un essere umano morente o gli innocenti uccelli che popolano il cielo di questo pianeta.
Nessuna tempesta ci infastidisce.
Il nostro sistema nervoso centrale è fatto di etere e della sostanza edenica che sta tra un’idea e l’altra idea.
Proseguiamo in avanti, un passo avanti dopo l’altro, quasi in carovana, non sappiamo quanti siamo o chi sia davanti, sappiamo soltanto di andare: andare avanti.
Ci accorgiamo di apparire, spesso contemporaneamente in due località, magari assai distanti, del globo. A volte siamo compresenti in più universi.
Vi abbiamo visto dai vostri primordi.
Eravate simili a ratti grossi come un bambino, grigi, la pelle viscida, l’occhio di koala, usciti con una dorsale molto morbida e cartilaginea dalle acque solforose dove eravate stati miriadi di girini, esserini spermatozoici inoculati per esperimento con certi becchi di Bunsen naturali.
Erano, quelli, tempi molto antichi, in cui il pianeta risultava incerto.
Infatti voi stessi vi chiedete: come nacque la luna? Quel satellite muto che da millenni gira intorno alla gran testa del pianeta, la quale a sua volta gira e rigira, come si formò? Come si fermò proprio lì attorno a noi?
Questa è una storia che i vostri padri non tramandarono, ma che non è detto non avere testimoni. Noi Cammelli Polari, se anche non interessati a quanto esternamente nel mondo andava conformandosi e indifferenti a tutto come nella nostra natura (e nella vostra anche, in realtà: epperò stentate a comprenderlo: perché?), avremmo davvero potuto vedere, desiderandolo. Non lo desiderammo. Ciò non significa che non conosciamo la risposta all’annosa questione della nascita del poetico astro satellitare, che debitamente definiste triforme. Conoscere e desiderare, infatti, sono due attività molto differenti e ben distinte, anche se nel caso vostro molta confusione viene fatta, e dai vostri filosofi innanzi tutto.
Come è che esiste la luna?
La domanda è piuttosto semplice ma la risposta finora data dalla scienza non è univoca, sebbene ormai tale quesito sia simile a una preghiera, per l’intensa volontà di conoscere la verità dei fatti riguardanti appunto la luna, e a quel pregar la nube fino a ora non aperse della nonconoscenza né la scienza né il gran filosofeggiare che se ne è fatto. Si è ridotta, nei tempi più recenti, l’umanità, che si stima oggidì conoscere grandemente i fenomeni celesti ignorando quelli interiori (che sono poi la medesima cosa), a non sapere rispondere a quella domanda semplice: che di zafiri, rubini, oro, topazi e perle, e diamanti e crisoliti e giacinti siano all’origine o appena sotto in forma fossile la superficie lunare non è agli uomini cosa nota, non diversamente dai padri dei loro padri per tutta la catena che li riportasse a quando ancora guizzavano nelle acque di fumigoso fango.
In pratica non è ancora cosa certa o certificata il come si sia formato il detto satellite.
Di recente hanno abbozzato l’ennesima teoria (che, come tutte le teorie, è una fola che incanta il popolo bambino degli umani) due insigni scienziati, il De Meijer sudafricano e l’olandese Van Westrenen. Nuova e rivoluzionaria ipotesi pubblicata per la prima volta sulla rivista Earth Moon and Planets International Journal of Solar System Science: la luna, dunque, si sarebbe formata a seguito di una molto potente esplosione nucleare.
Non che la scienza non abbia già tentato, con i suoi modi e i suoi tempi, di spiegare per quale motivo, appeso lì a mezzo nel cielo, cangiante a seconda della gradazione della luce che riflette, coi suoi basalti neri e specchianti, ci fosse questa palla che stupefà bimbi e bimbe quand’acquisiscono quel poco di senno per capire che lì c’è un altro pianeta oltre il nostro.
Una prima ipotesi era quella della cattura. Ci si figurava, in pratica, che la luna si fosse venuta addensando in una zona diversa del sistema solare, per poi risultare fatalmente attratta dalla gravitazione del mondo. Una ipotesi ulteriore riteneva che terra e luna si coagulassero, insieme ma in forma separata a partire da un cosiddetto disco di accrescimento primordiale, che potrebbe ricordare una dolce aura che ti par che vaghi facendo così l’aria tremolare intorno, vibrando le materie dei due corpi celesti. Non convincendo gli umani questa seconda teoria, coloro ne svilupparono quindi una terza, e cioè della fissione: in pratica la luna si sarebbe staccata dalla terra per effetto di forze centrifughe, creando un immenso bacino. Una simile centrifugazione, tuttavia, una volta andatasene nel cielo la luna, avrebbe pur lasciato un avvallamento sul pianeta! Ma questo non si trova! Dunque ci si misero, gli umani, a invalidare con questa argomentazione la terza teoria e ne idearono infine una perlomeno non contestabile con effettualità e prove: e sarebbe, questa ipotesi, la teoria dell’impatto gigante. Ovverosia viene ipotizzato un memorabile scontro con la terra da parte di un corpo celeste dalle dimensioni perlomeno di Marte, e dall’impatto si creò sufficiente materiale in orbita dintorno alla terra perché si formasse dunque la luna. Polvere alla polvere, quindi. Tuttavia non esiste prova che la terra abbia mai posseduto un oceano di lava come previsto da detta ipotesi (e invece lo possedeva: noi Cammelli Polari incedevamo a quei tempi, lo sappiamo bene, in mezzo alle fiamme).
Lo studio citato, quello del De Meijer e Van Westrenen, azzarda che la terra primordiale fosse un corpo rotante in rapidissimo (quasi inimmaginabile da quanto era rapido!) movimento, laddove le forze centrifughe erano minimamente inferiori a quelle gravitazionali. In questa situazione ripetuta, spiegano i due ricercatori, un anche trascurabile incremento della velocità angolare avrebbe permesso a una consistente massa di staccarsi dall’equatore. E come si sarebbe generato questo aumento di velocità? Il De Meijer e il Van Westrenen non dubitano che ciò si sarebbe verificato mediante una esplosione nucleare di un georeattore naturale. Le forze centrifughe, come in una lavatrice che perdesse di colpo le pareti e l’oblò, avrebbero concentrato gli elementi più pesanti, come uranio e torio, vicino alla superficie terrestre e sul piano equatoriale. Una simile alta concentrazione avrebbe dato vita alla esplosione che permise il distacco della luna.
Sia detto che l’effettiva esistenza dei georeattori naturali è indubitabile. Nell’anno 1970 umano occidentale, è stata difatti documentata l’esistenza di un georeattore che era stato molto attivo due miliardi di anni addietro a Oklo, proprio nel Gabon.
Ecco dunque il motivo per cui i padri non poterono tramandare questa storia: ancora non c’erano padri. Non c’era nessuno, qui, e noi Cammelli Polari possiamo testimoniarlo con tutta la tranquillità che ci contraddistingue.
Ciò significa che la vostra impermanente specie (poiché alcuni esemplari umani ci scorgono appena, transitori e impermanenti, verrebbe da pensare che noi siamo una specie impermanente: e invece siete voi gli impermanenti, che soltanto raramente riuscite ad affacciarvi al di fuori di quel carcere in cui vi siete infilati e a togliervi quelle spesse lenti affumicate che vi ottundono la vista) cerca di ricordare qualcosa che non ha sperimentato. Il che, a sua volta, significherebbe che, in fondo, avete ben compreso come la memoria sia una forma di fantasia, soltanto più grossolana e apparentemente coerente, cioè allineata a quella barra plumbea su cui pensate di camminare prima di precipitare nel nulla – la quale barra sarebbe il tempo.
Ora, questo nostro discorso, che abbiamo atteso lunghi millenni per pronunciare, dichiarandovi apertamente come siamo fatti e ammettendo che, a differenza di voi, non disponiamo della cosidetta intimità, sta proprio qui, considerata la vostra propensione a prendere per vero ciò che è immaginato – la quale a sua volta è una verità vera, letteralmente vera, ma che tutti voi ritenete, se pure ammissibile, in realtà non vera e vivete come se, essa, vera non fosse né reale: del tutto o in parte.
Quindi il nostro discorso si raggrincia in una semplice, estensibile domanda a voi posta: come fate?
Come fate?
Abbiamo visto molti di voi disperdersi vecchi o pronti per diventarlo, nelle ore tumultuose dei lavori innaturali con cui ingannate più voi stessi che il tempo (vostra indecrittabile fede, e invece fidejussione a tutti gli effetti). Vi abbiamo scrutato inerti sulle panche di granito lucido piantare le suole nelle tacche di gomma nera consunta e insozzata delle pavimentazioni nelle fermate di metropolitana, le mani pallide ancorate al corpo come appendici di un arcipelago esistito e poi frantumato da un immane sisma, le rughe a vent’anni decapitarvi il collo tornito per dimostrare che nutrirvi non è più un problema o un pericolo, le sopracciglia modellate da un’estetica tremendamente artificiosa, la quintessenza di quello spettro vagolante per il globo terracqueo che celebrate come moda, che sarebbe una medesima inclinazione della vita dei nervi, ovunque siate e vi troviate, a compiere e baciare l’ano all’oggettistica e agli idola tribui, alla mamma e alle fatine, alle consultazioni elettorali e alle settimane bianche, ai giorni neri, ai periodi grigi, alle nozze d’argento, all’età dell’oro. Vi abbiamo scorto aggirarvi per queste città dolenti, sempre in più dolenti climi immerse, senza nemmeno immaginare l’esistenza di cieli o tantomeno di cieli altri, mentre i platani si ammalavano dei loro cancri colorati e le pietre miliari si sbriciolavano dopo avere fissato immaginari confini all’occidente. Le vostre teste stanche la sera dopo i trigliceridi ingurgitati, manducati con le ptialine ingenerosamente facendo a meno di accorgersi, fuggendo la Dea Attenzione come una spavalda Medusa che non si ha il coraggio di combattere. Senza più aggrapparvi (con lo sguardo, perlomeno!) ai monumenti che in un altro tempo per altri motivi dai vostri (che vi spingono a interpretare, interpretare, interpretare!) eressero simmetrici e distinti, asserviti a signorie indegne.
Come fate?
Millenni trascorsi a scorticare la carne, a sfrigolarla, a manutenerla nell’orcio, salandola, ruminandola: ed era quella di uomini simili a voi in tutto e per tutto. Ignorando gli angeli o asserendone l’esistenza, ma comunque sbagliando. Anni di errori e di miscredenze e di fraintendimenti e di duro lavoro a impiantare tra i Sali pesanti e i fumi della terra a stagioni alterne seminagioni e sfregare i calli contro le radici della vegetazione prodotta, calcata come le bietole e le barbe in pentole ribollenti, aspirando fumi di questo fango detto natura. Disperatissimi, angosciatissimi, spalancando il poeta gli occhi acquosi enormi e vitrei nella città luminosa all’inizio di un secolo non più maledetto e rovinoso di altri.
L’uomo: questo pupazzo giudicante.
Sbagliereste a ritenere “buona” la nostra perenne e inscalfibile indifferenza.
L’episodio capitato al poeta, che si aggirava nella capitale della vita nervosa, si ripete accelerando la frequenza con cui si manifesta, moltiplicandosi in una legione di soggetti sempre più contemporanei, sempre più estesa la legione.
Perché nelle grandi città non esiste nessuno che li aiuti?
Sentiva che avrebbe finito per restare tra i perduti, preso nel sacco dell’esistenza irrimediabile.
Il destino, infatti, è libertà, non necessità. Soltanto nel caso che non ci si conosca, succede che si ritenga necessitato tutto ciò che accade o che si compie.
La nostra necessità è un atto di pura spontaneità e in ciò risiede, eventualmente, il sublime che esprimiamo: nell’occhio di chi riesce a scorgerci.
Quell’uomo poetico osservava di settimana in settimana, riparandosi nella stanza gelida con il pavimento in assi di legno lerce consunte, osservava progressivamente rovinarsi i propri vestiti, li ravvedeva lisi in molti punti: questo è il tempo, il logorare. Perciò temeva quell’uomo di rimanere tra i perduti di quella sconfinata metropoli, un aggregato umano malato e perduto per sempre alla gioia della vita grossolana.
Una volta quella persona poetica, che incidentalmente studiava alla Biblioteca Nazionale, intraprese un cammino per i grandi viali della città, una strada a carreggiata irregolare confluiva in una vasta piazza ovoidale, irregolare, e lì vide il rosso della vernice delle carrozze, tutto ciò che è mattino, la freschezza e il chiarore e l’energia. I richiami dei venditori che bagnavano gli ortaggi e qualcuno in fondo alla piazza, che l’attraversava obliquo, vestito di verde chiaro, conferivano a quel momento una saldezza che mai più sarebbe stata sperimentata.
Quando a ogni respiro si ha la sensazione che la terra manchi, che l’abisso si spalanchi, non avendo minimamente timore della fine, però col terrore dell’imminente caduta, sempre imminente, questa imminenza è l’unica forma di continuità.
Allora lo vide. Un uomo magro, vestito di nero, camminando si tirava giù il bavero del soprabito con entrambe le mani, il bavero si rialzava, irritandolo. Affaticato da questa operazione ripetuta, continuamente ripetuta, non riusciva l’uomo in nero a badare dove appoggiava il piede e inciampava o anche riusciva improvvisamente a schivare di scatto un qualsiasi minuscolo ostacolo. Eppure, si avvide il poeta, che era già sconcertato da quell’apparizione scura, la camminata dell’uomo niente aveva a che fare con il marciapiede, che era liscio e regolare: quegli, di fatto, pareva quasi che intendesse ingannare chi incrociava, voltandosi ogni qualvolta avesse inciampato, per prendersela con qualche ostacolo per l’accaduto! E in realtà non c’era niente. A tratti quell’uomo in lenci nero riprendeva un’andatura regolare, camminando spedito passava così inosservato. Poi riprese il tremito, questi scatti degli arti.
Va meditato il fatto che, camminando spedito, un essere umano passi inosservato. È infatti questa la vita dei nervi a cui alludiamo: una forma patologica distante dalla natura angelica. Dove siete finiti per stare, in modo tale che accadesse uno scempio simile di tutti voi?
Il tremito, dunque, aumentò di nuovo, manifestandosi all’improvviso, dal nulla, questa volta alle spalle, che sollevò di scatto per due volte e fece ricadere immediatamente, lasciando penzolare le braccia di traverso mentre continuava a camminare. Con una rapidità fulminea si vide la sua mano sinistra portarsi al bavero del soprabito e quasi inavvertitamente afferrarlo, come fosse quello di un estraneo che gli manifestava ostilità, e lo sbottonò in un istante; e poi ricominciò ad abbassarsi il bavero medesimo, armeggiando con entrambe le mani in una maniera ardua e disarmonica, mentre annuiva con la testa in avanti e verso sinistra, allungando il collo e non smetteva un attimo di annuire.
L’effetto di una simile visione, mentre già alcuni addetti di un locale pubblico, che sistemavano le sedie fuori, al fresco, per i consumatori a venire, fischiavano verso l’interno a richiamare l’attenzione dei barman sulla sagoma che procedeva per tic dell’uomo in nero – l’effetto che ebbe su chi scrive questa visione fu un movimento a spirale e a imbuto, che attrae in questo istante il suo sguardo dentro lo sguardo acquoso del poeta che osservava la scena, ed entrambi gli sguardi, fattisi uno, finiscono a spirale verso il bavero del soprabito dell’uomo in lenci nero, avvertendo l’angoscia, la consistenza di frammenti di forfora, la sua inadeguata motilità nei globi oculari, la dermatite bilaterale all’interno del canale auricolare.
Ci manifestiamo piano, a intervalli brevi.
Questo contagio nervoso, questa nebulosa di tic, che abbiamo osservato trasformarsi rapidamente, negli ultimi secoli, in una diffusa pandemia tra la specie umana, fa di noi Cammelli Polari un indice di riferimento quasi insostituibile, per coloro che volessero comprendere dove ha inizio la patologia e dove ha fine la cura. Coloro infatti che imparano a vederci, e cioè imparano a vedere (poiché, infine, la questione risiede tutta qui: da tempo immemore, da sempre, per chiunque, compresi noi, immateriali battriani, il problema è imparare a vedere), al tempo stesso possono dirsi colpiti da quella malattia e pronti per essere curati: ognuno di questi rari umani si sta curando a tutti gli effetti, ma tale cura apparirà, ai suoi sensi scossi, come la malattia stessa, ne avvertirà effetti collaterali in veste di autentici sintomi, e vivrà per molto tempo nella confusione di un convalescente che sia ricaduto nell’afflizione.
È perché siamo stati una specie afflitta, molto afflitta, che noi Cammelli Polari possiamo incedere in una suprema indifferenza, osservando senza osservare, se così possiamo esprimerci, i vostri affanni stupefacenti e le vostre scandalose ma innocenti ignominie.
Colui che scrive questo nostro discorso, per esempio, è un soggetto interessante: infatti egli ci ha veduto. Ma osservate in quale stato egli è ridotto! Prostrato, fatica a pronunciare le parole ai suoi prossimi. Il lavoro lo strema. Non morde nulla della vita che gli altri umani conducono, ritenendola loro la medicina che pone termine al guasto della vita dei nervi. Egli scrisse, un tempo; ora non più: eppure, a vedere la cosa in modo grossolano, sta pur sempre scrivendo. E questa allucinazione (ravvedere dal corpo chino sui tasti un uomo e supporre che egli scriva, addirittura giungere a leggerne le parole: ecco un sintomo tra i minori della patologia umana) è incurabile finché quest’uomo non decida egli stesso di scomparire alla vostra vista, che è rude e imprecisa, essendo le vostre diottrie confuse dallo stato di cose a cui il mondo vi espone di ora in ora. Qualche barlume deve pur averlo intravvisto, chi trascrive il nostro discorso – poiché riesce a decifrare il nostro sibilo in ultrasuoni e a vederci pallidamente all’orizzonte camminare. È sorpreso al punto che si attende quasi una superna rivelazione da noi, quest’uomo: vedete che è indiscernibile se egli sia malato o stia guarendo? Ogni giorno si sveglia lancinato dal panico, lo sterno dolorante per l’ansia che da dentro preme e si alza dal letto posando la pianta del piede nudo sulla piastrella fredda di colore ghiaccio, e avanza verso la sostanza plumbea della luce fisica mattutina, fino a ricordarsi come è fatta la sagoma grassa e pachidermica del suo corpo più pesante. Tutto è per lui morto o come tale. L’avvenire lo terrorizza. Non gode di amore, pur essendone assediato. Non sa come fare. Le sue amiche corrono in soccorso a lui. Vorrebbe slacciare gli arti, un povero cristo morto privo di sudario e dei tre giorni di prammatica per riaversi e riprendersi in autentica, grande salute. La sua psiche vacilla. Non crede di coincidere con alcuna personalità psicologica, eppure ciò lo devasta di paura. Avverte di essere un nessuno, una nebula di elettroni che vaga per una via di una cittadina in decadenza soffrendo, soffrendo immensamente. Non c’è limite alla sua sofferenza, poiché la radice di tale dolore non è clinica, forse neppure spirituale. Adotta un’estrema cautela, eccessiva per dirla francamente, come rimedio a quella che avverte e interpreta in qualità di aggressione del mondo, mentre si tratta dello spigolo naturale proprio del mondo stesso, la botta dell’essere in quel posto in cui vi ostinate a stare: spigolo duro, che si abbatte contro il legno fragile e concavo dello sterno. La cultura è morta per lui, quasi come il piacere. Non desidera esistere, ma sa perfettamente che non può domandare a questa vita di lasciarlo perdere, poiché perfino questa indecenza, che la vostra specie ritiene essere l’unica e la reale, è essa stessa vita, e non prima di averla assaggiata la si può dimenticare, sussumendola in sé stessi.
Quest’uomo, vedete, si passa una mano tra i capelli corti e unti. Non vestito in lenci nero, è il poeta angosciato che vide nella capitale l’uomo dei tic e al tempo stesso è l’uomo dei tic vestito di scuro: è entrambi e in ciò risiede in parte il suo dramma. Ha in odio il suo nome.
Un pulviscolo di cognizioni che i cervelli umani, piccole retìne per pesci rossi, raccolgono nell’aria, questa polvere di minuscoli o giganteschi e “sì” e “no” – è la forma terroristica con cui l’ultimo sintomo, prima di un buon cambiamento, avverte la vostra specie che siete chiamati a rispondere alla domanda, che noi medesimi ci siamo permessi di porvi: Come fate?
Scrivere non è più la forma con cui viene riversata nella bocca cerebrale e nervosa, spalancata per il desiderio di salute, la medicina buona che annuncia il cambiamento buono. Scrivere non è più assolutamente alcuna forma. Lo scrittore è diventato un sintomo stesso, e minore, della patologia. La lamentazione sullo scrittore è già stata espressa, rappresentata, logorata – per cui non si può più dilazionare nulla: si può solo osservare che la sagoma di piccolo pensatoio e di antenna vibratile e di praticone della cristalleria linguistica è definitivamente tramontata.
Tra quattro secoli, ammesso che esistano ancora fisicamente e non altrove, gli umani dismetteranno perfino la parola, la fonazione.
Noi stessi sembriamo faticare a persistere con il nostro inaudito sibilo in ultrasuoni.
L’irritante sobillare degli scrittori contro gli scrittori è stato concusso in un secolo in cui la specie umana è divenuta capace di decidere se sterminarsi fisicamente o sopravvivere tra le mangrovie dei suoi esordi. Gli scrittori hanno sputato sentenze contro gli scrittori: è, come bene si nota, la forma ultima dell’esorcismo. Hanno articolato discorsi scritti, al fine di rimandare la semplice constatazione che lo scrittore è terminato. Hanno scritto che lo scrittore corteggia il proprio pubblico ignominiosamente quanto l’uomo politico, gli piace tastare il gran polso, prescrivere ricette come un medico, conquistare un posto tutto per sé, essere riconosciuto come una forza attiva, bere la coppa colma dell’adulazione, anche se questa dovesse essere rinviata di mille anni. Volevano restare, gli scrittori? Un paradosso degli umani alla loro fine: tra loro, quelli che non credono al tempo desiderano in fondo restare nel tempo. Gli scrittori, hanno scritto gli scrittori esausti prima che la patologia divenisse pandemica, non vogliono un mondo nuovo che potrebbe essere organizzato immediatamente, perché costoro sanno nel profondo dei cuori che un simile nuovo mondo non farebbe mai al caso loro. E si dà invece che accada proprio questo: all’improvviso, un nuovo mondo, organizzato immediatamente – e tutti ci precipitano dentro, si svegliano lì, che è già bell’e che fatto, come quando si nasce, si inizia un sogno, oppure si muore fisicamente. Il vecchio sogno di potere dello scrittore è stato smascherato da moltissimi anni, e ancora gli uomini persistono nell’abusata lamentazione: lo scrittore desidera un mondo impossibile nel quale egli sia il governante senza corona.
L’immagine è questa: dai lati opposti di un tronco di quercia plurisecolare, larghissimo, si dipartono due cavi sottili metallici, discendendo tesi questi verso un assai lontano fuscello di giovane quercia, e si uniscono quei cavi in un medesimo punto, penetrando la scorza del giovane albero, annodandosi nel legno. Due gocce di olio putrefatto e puteolente scorrono in parallelo, fuoriuscendo distillate dalla quercia antica, percorrono parallele lo spazio veicolate ognuna dal propio sottile e resistentissimo cavo in metallo, finiscono nel punto unico in cui i due cavi si uniscono, intrecciandosi al virgulto, che miscela nel suo fusticello le due gocce oleose di putredine, e si unisce a queste e le unisce alla sua giovane corteccia ed ecco che viene coagulata un’unica resina in goccia, da quei tre elementi, profumatissima, poiché ognuno degli elementi, preso a sé, non significava nulla.
Le due gocce che corrono parallele sono l’umano che scrive e l’umano che legge.
Il fusto giovanissimo è il mondo nuovo, che sta per apparire istantaneo.
Ora all’uno ora all’altro, la grazia che vivifica guarda propizia.
Cadrebbe in un grave errore chi pensasse che noi, i Cammelli Polari, indifferenti a tutto poiché concentrati su un unico punto (senza requie ci chiediamo, con una domanda priva di parole, che cosa sia davvero un punto), fossimo stati istruiti da Demetra come Trittolemo o i principi di Eleusi, in modo da celebrare sacri riti, e cioè quei riti di cui nessuna lingua può parlare. Solo, dicevano gli antichi umani, sia benedetto colui i cui occhi hanno veduto quei riti: il suo destino dopo la morte non è uguale a quello degli altri umani. E nemmeno sussurrammo al modo che sappiamo (e che voi ora conoscete) a quello scrittore che vide il Cristo e prese appunti su quanto disse e iniziò il suo quaderno segreto osservando: “Chiunque trova l’interpretazione di queste parole non conoscerà la morte”. Quanto si sono intestarditi gli antichi padri affinché i futuri figli smettessero di giocare nel fango, con enorme danno ai proprii sistemi nervosi centrali o periferici…
E cadrebbe in errore anche colui che ritenesse la nostra specie “al di sopra delle parti”. Istantanei quali siamo, inafferrabili eppure (in un certo modo, per stare alla lingua abusata) angelicamente necessari, induciamo nel grave errore per cui, presiedendo all’osservazione di molte specie e di infinite storie in universi che superano perfino il numero infinito, noi saremmo privi di vizî o di guasti, poiché prescinderemmo da ciò che si manifesta. Ciò è impreciso e crederlo costituisce un rischio ben più che morale, a cui qualunque Cammello Polare è esposto durante l’intera sua esistenza, che la vostra specie non può calcolare nella sua estensione, poiché non esiste estensione. Noi siamo invece la manifestazione. Ciò che si manifesta, si manifesta in noi. Tutto ciò che si manifesta, si manifesta al modo in cui ci manifestiamo noi. Tutto ciò che si manifesta pretenderebbe di essere più di ciò che si manifesta, il che capita anche a noi.
Noi infatti siamo presi da tutti i vizî e tutte le virtù, che ci fasciano come ampi raggi larghi in banda di una luce non fisica, ma ancor più sottile della luce usuale a voi umani: fasce multicolori come pashmine iridescenti o livide e oscure come solenacee voraci – sono le virtù e i vizî medesimi che affliggono le vostre microscopiche esistenze fisiche, rispetto ai quali siete tanto disattenti! Noi Cammelli Polari, semplicemente, abbiamo a lungo osservato, scrutato e discriminato, dopo un iniziale e sbalorditivo terrore, queste potenze numinose ed elettriche, giungendo alla conclusione sperimentale che noi eravamo da queste mossi, al modo in cui sono mosse da altre potenze le marionette. Siamo stati all’erta per cicli di tempo che non potete considerare plausibili. Agiamo affinché tali potenze si esprimano senza danneggiare i mondi in cui camminiamo in fila. Scontiamo il peso della loro presenza, della loro densità ancora non disciolta nei nostri corpi albini e luminosi.
Per esempio, noi coviamo, per voi inaspettatamente a questo punto, un’invidia che ci corrode impietosamente e ci lascia attoniti, se solo riusciamo ad accorgerci che ne siamo presi. Noi vorremmo infatti tutti non essere la specie indifferente dei Cammelli Polari: desidereremmo appartenere (ognuno di noi!) all’ammirata specie dei Cammelli Solari, che voi umani non avete mai scorto né potrete mai intuire, essendo tale specie al di là delle comprensioni formali dei più acuti individui bipedi che stramazzano dopo sette decenni di resistenza a questi gas tossici ma vitali per voi, ossigeno e idrogeno.
I Cammelli Solari: se solo voi poteste intuirli anche solo per un istante! Anche solo di scorcio oppure in sogno!
I loro corpi traslucidi vanno nella luce matura dell’astro, tremuli confini di peluria sottile, affocata… Conosciamo la loro pastura di sangue innocente e volontà di essere, che non incrina mai la mancanza di pensiero e di sacrificio con cui procedono verso il centro, lasciando che il loro immane cuore comune esprima pulsazioni meravigliose… La loro giugulare è una strada che conduce a conoscenze non trasmissibili, la loro vita tutta è un tuffo nell’annegamento più delizioso… E ci insegnano quanto sia male esistere e bene essere, ci adottano ignorando perfino il fatto che siamo apparsi, molti strati geologici di luce inferiori, in questo spazio immenso in cui nulla muta e nulla si distrugge… Sperabilmente ambiamo alle loro inequivocabili assenze di virtù e di vizî, procediamo nel profumo di essere che imperla universi a goccia nel crepuscolo di questo stare, prima che in un vortice momentaneo tutto si riassorba nell’essere ora e sempre non più, l’inesprimibile caos della vigilia addivenendo la muta potenza di qualunque parola, e i nostri sguardi umili finestre immobili nel disco dorato dell’astro che ha dominato qualunque specie, qualunque sole su qualunque terra, indifferente e intangibile mentre sotto il suo dominio crollavano i regni colossali eppure minori, trombe di aria polverosa immani conducevano atmosfere a gradi intollerabili di tossicità e fastidio, e il gioco temporale del dolore aveva luogo sotto una luce che lasciava ancora spazio all’ombra, per una pietà meccanica che non ha ragione di venire espressa…
Così, se anche uno di noi, immediatamente, fosse ammesso alla presenza dei Cammelli Solari, questi esseri immensi, arcontici, dagli zoccoli di metallo istoriato e le labbra umide di arnica e di più varie mirre, lo sguardo fisso nell’astro indomito del sole che tutti ci rappresenta, noi finalmente, i suppostamente serenissimi Cammelli Polari della specie che è apparsa pallida all’orizzonte quasi orientale nei quadranti umani, e nella quale colui che sta decifrando il nostro discorso ha tanto sperato, quasi fossimo messaggeri od operai di un segnale divino o semitale, ecco ci discioglieremmo come voi entrate nel sonno, a piedi uniti nell’acqua buia in un tuffo perfetto e verticale, in un battito di ali di insetto, oramai privi di voce, questo tremendo sibilo che emettiamo senza posa…
Noi li invidiamo. Se riuscissimo a scavare in questa potenza oscura e neghittosa, questa che diciamo invidia, noi sappiamo cosa incontreremmo: le immagini di noi cibarci della carne aurea dei Cammelli Solari, dopo averne abbattuti i corpi, desiderata la loro morte come se fosse la nostra nuova vita, l’esplosione del loro muscolo cardiaco in uno spruzzo luminoso contro il regime abbagliante del sole, appropriandoci dei loro zoccoli arabescati, grandi quanto la città di Tulsa ognuno, il furto della saggezza per onde mentali da conservare nei nostri corpi troppo piccoli e fragili per contenere una simile potenza, trapiantare i loro occhi infrarossi nelle cave dei nostri scheletri poco rinomati, e dare fuoco sacrificale alle loro ossa, sputando sui brani di carne residua e maledicendo quella specie per la sua sorte così suprema, così inguardabile, così benigna e insuperata!
Noi vorremmo infine essere, al pari di tutti gli esseri finiti, gli assassini della luce e i latori del buio definitivo, senza scegliere.
L’invidia è lo stato innaturale di qualunque aria, la motivazione centrale della resistenza ch’essa oppone al movimento.
La requie è lo stato naturale di tutte le cose quando avranno terminato di essere cose e si saranno ritrovate a essere una cosa unica.
Per questo e altro noi vi diciamo, piccola specie angelica inerme e colpevolissima: tornate alla casa.
Siate amiche e amici.
Il bene si sente senza mediazioni.
Il tempo è finito sempre.
C’è un punto che si supera e tutto siamo noi.
Figli monocoli della terra, spalancate il vostro occhio unico, pronti alla scomparsa che nessuno benedice, nessuno maledice.
Il silenzio è l’origine e la compresenza delle sinfonie tutte.
Chiunque abbia calcato un territorio era un angelo inconsapevole o consapevole.
Reggimento del angeli: scomparirà anche questo.
Uomo che ci hai decifrato: grazie, amore – pace.
L’impermanente specie dei Cammelli Polari».
Amiche e amici,
qualche parola ancora per raccontare la vicenda breve dell’uomo a cui capitò di decifrare, per caso o per destino, il che è identico, il discorso che la specie impermanente dei Cammelli Polari desiderava fare a quella umana e da sempre, in effetti, faceva, senza che alcuno interloquisse o anche soltanto porgesse l’orecchio a quanto veniva pronunciato.
Era la domenica 14 marzo 2010 ed egli era disperatissimo. Aveva accarezzato la bambina che amava, il mattino, e la madre di lei, che pure amava, il mattino. Si era seduto di fronte a loro, imbambolato, faticando tanto a discorrere e a calcolare i movimenti e gli atti. Quando le amate furono allontanate, anche per l’azione di un moto suo dell’animo nerogrigio a centrifuga dallo sterno di energia che respingeva, egli ritornò solitario nella casa e incominciò ad avvertire il tremito nelle braccia, i centri nervosi vibrare e gli arti intorpidirsi quasi per un eccesso di elettricità interna. Mangiò poche fette di formaggio, accompagnandole con pane industriale ai cereali. Sbocconcellava il cibo. Pensava alla vita volatagli via: la futura. Si sentiva prigioniero di un carcere aereo, ubiquo, immateriale, che proveniva dal futuro, dove ogni movimento sarebbe stato impedito e qualunque evento si sarebbe verificato in una zona a lui morta. Nell’interiorità i fenomeni psichici e nervosi gli sembravano cadere verso il basso, verso un fondo, quasi fossero cose inanimate, oggetti pesanti. Non aveva imparato a vedere e desiderava al più presto di morire. Un giorno aveva scritto, non essendo scrittore. Per molto aveva inutilmente pensato. Ciò che intendeva di fare, e cioè osservare un punto unico in silenzio, se lo impediva con il proprio corpo e con la propria mente volatile, preoccupatissima, instabile, afflitta da immane motilità.
Sua madre gli aveva regalato una lozione antroposofica per rasature e lui se la cosparse sui polsi. Immerse la lametta industriale molto affilata in quella lozione dolciastra. Premette. Andò a dormire. Si risvegliò. Rilesse.
Fu obbligato alla vita, questo residuo di amore che doveva apprendere ad amare e non sapeva come fare.
Non seppe come fare, restò molto zitto.
Accelerammo con lui verso l’inestirpabile radice di qualunque esistenza, priva di luce e ombra, inarrivabile da ogni lingua e lignaggio, accelerammo a qualunque sempre, oltre le poverissime verità, senza nessuna storia, privi di qualunque tratto, noi: i disciolti, la pace.